I primi quattro contributi di Laura Carroli, Steno Nap, Oddone Ricci e Marina Zoni qui di seguito sono le prefazioni al testo del romanzo, quella di Riccardo Pedrini è la postfazione.

Quando stai vivendo qualcosa di speciale non è facile averne la consapevolezza, di certo non quando si è giovani, guidati dall’impulsività e, per dirla con gli Stiff Little Fingers, sei «Inflammable Material». Poi passano gli anni e ti ritrovi dentro a un romanzo come personaggio, ci sei tu e ci sono i tuoi amici di allora che poi sono gli stessi di adesso. Si ricordano insieme gli episodi vissuti, ognuno ne ha una propria versione, uno scambio di particolari e i pezzettini si ricompongono, sembra quasi di vederli in un film.
Altri avvenimenti sono spariti, cancellati per qualche motivo che forse solo Freud capirebbe, le emozioni no, quelle rimangono sempre, i sentimenti sono solchi di un disco che ancora gira.
Perché si fanno certe scelte? Cosa trainava le mie azioni? Rileggo i diari che ho tenuto e sono certa che a spingermi siano stati due elementi: la noia e l’amore, il primo ha intriso i miei giorni e le mie notti fino a che non ho cominciato a essere attivamente parte di una scena. Per quanto riguarda il secondo, non ho dubbi che abbia accompagnato tutte le scelte della mia vita e per amore intendo anche il sesso.
Il punk ha cambiato la mia vita, ero una ragazzina da tappezzeria, come direbbe Stephen Chbosky, una che non avrebbe mai parlato in assemblea, né a quelle del liceo tantomeno a quelle dell’università dove infervoravano i discorsi di Bifo e Pino Angoscia. Conoscere i primi punk a Londra fu dare il fischio di partenza al treno e una volta messo in moto le carrozze si sono riempite e il viaggio è cominciato.
Un’aliena annoiata, così mi sentivo, lontana da tutti e incapace di trovare qualcosa che si adattasse a me ma è stata proprio questa insoddisfazione a darmi l’impulso a fare, se il ristorante non offriva niente che fosse di mio gradimento perché non mettersi a cucinare i miei piatti preferiti. Il punk aveva un grosso vantaggio, aveva distrutto i virtuosismi e con essi l’«aristocrazia della meritocrazia», non occorreva essere bravi, quindi anche una priva di talenti come me poteva.
Quando ero un’adolescente andavo a ballare nelle discoteche la domenica pomeriggio e mi piaceva scatenarmi seguendo ritmi che erano solo nella mia testa. Una volta fui chiamata da un gruppo di bullette che mi sussurrarono all’orecchio di spararmi in bocca. Quelle parole mi ferirono così tanto che da allora non riesco più a ballare con quel trasporto, diventai consapevole di non andare a tempo, fu come mangiare la mela nell’Eden. Venni liberata dal pogo, finalmente potevo lasciarmi andare e venire trascinata dalla musica senza paura di essere giudicata, riuscii persino a suonare la batteria in un gruppo per la bellezza di sette anni.
Non so nemmeno io come ho fatto e non importa se erano gli altri a venirmi dietro, il mio tempo batteva secondo il ritmo di un altro sistema solare, creavo i miei tempi secondo schemi che non erano quelli delle hit parade. Come tutti i punk sfoggiavo bondage e catene, l’attitudine di rifornirmi in ferramenta anziché in gioielleria veniva da un’attrazione istintiva verso tutto ciò che era punk ma poi riuscivo a capire che c’era anche qualcosa di più.
Mi piaceva giocare con la schiavitù e mostrare apertamente che tutti siamo prigionieri, lo siamo ancora e forse ancora di più, per questo uso il presente, in fondo sentivo che le imposizioni erano tante anche nel mondo del movimento dal quale provenivo, mi sentivo ingabbiata dalla famiglia e dalle lotte politiche, il punk evidenziandolo mi faceva sentire libera.
Più ero bersagliata da critiche e insulti più mi sentivo libera, si cominciava al mattino e si finiva quando si andava a letto, c’era però la musica che aveva il potere di una corazza, la forza di un attacco nucleare e l’attrazione della forza di gravità, era come immergersi in un bagno sonoro e uscirne ricoperti. Sentirsi soli però non è una gran bella sensazione, quando tornai dal festival di Reading nel ’78 sentivo che dovevo trascinare in quella magnifica follia tutti coloro che conoscevo, compreso quelli che avrei conosciuto in futuro.
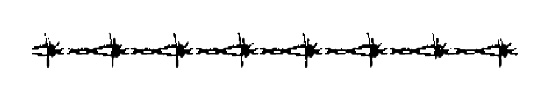

Dopo aver passato 3 anni in un istituto di correzione, modo carino per definire il riformatorio, faticai non poco a ritrovare la mia normalità.
Il movimento studentesco mi era passato dentro senza troppa sofferenza, fatta eccezione per la morte di quello studente: Francesco Lorusso, ucciso da una carabina nelle mani di un carabiniere… così riportava un giornale della città. La morte di Francesco sancì ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la fine di quella storia e quel modo di fare politica non mi apparteneva.
La vita in quartiere era la solita, non ti regalava niente, tutto era rimasto come allora, nessuna possibilità di avere una casa, un lavoro degno. Dal ghetto non si esce… questo dicevano le facce dei miei fratelli di strada, quella che prima era stata la mia vera famiglia, adesso era lontana anni luce.
Passavamo ore, giornate, seduti su un muretto a decidere cosa fare, l’avevamo chiamato «l’angolo dello zombie» perché di questo eravamo certi, siamo zombie senza un futuro, lo scrivemmo anche sul muro di quell’angolo che delineava il nostro territorio… noi siamo quelli di «SANDO» qui ci siamo noi.
Amavo il mio quartiere, amavo i miei amici, noi contro tutto e tutti, pronti a combattere, nessuno di noi sarebbe mai scappato lasciando un fratello in difficoltà, siamo di SANDONATO cazzo! Finalmente una macchina… finalmente potevamo oltrepassare il confine, cominciammo così… in questo modo a frequentare locali e persone lontane dal nostro territorio, ci rendemmo conto che non eravamo così soli come credevamo.
Fu proprio in una di quelle occasioni che per la prima volta ascoltai una canzone di musica PUNK … erano i DAMNED era il 1978, rimasi folgorato, era quello che cercavo senza saperlo, quelle note, quei suoni cattivi erano la colonna sonora della nostra vita di merda.
“I FEEL ALRIGHT” una cover di un vecchio gruppo che si chiamava STOOGES, il tizio che cantava era un certo IGGY POP. La strada era stata spianata… adesso sapevamo cosa fare… adesso sapevamo come…


(a punk remember)
Per me il punk fu una ribellione sfacciata e creativa, ironica e anarcoide, una valvola di sfogo alle pulsioni che si agitavano in me. Un me all’epoca quasi ventenne, piuttosto insoddisfatto, che si trascinava a fatica tra gli studi universitari da poco intrapresi e le crisi domestiche (sempre più frequenti) con un padre autoritario vecchio stampo. I miei amici erano più o meno nelle mie stesse condizioni, chi preso da un lavoro, chi dallo studio, entrambi sempre poco gratificanti. Il bar coi suoi biliardi, la discoteca, il “fumo” e la locale sezione della FGCI erano, a vario titolo, i “rimedi” più diffusi a questo comune mal di vivere.
I tempi erano maturi per un cambiamento, e quello di lì a poco arrivò. Il primo contatto col “nuovo verbo” lo ebbi un venerdì notte, al buio della mia stanzetta, mentre scoglionato giravo la manopola del mio radiolone portatile Philips, passando da una stazione all’altra…era il 1978, epoca di radio libere e l’etere cittadino era invaso da decine di emittenti locali che trasmettevano di tutto, soprattutto stronzate, ma non quella notte. Infatti mi fermo all’improvviso su due voci che parlano dei Beatles… i conduttori stanno spiegando con dovizia di particolari la genesi di «Sgt Pepper» intercalando aneddoti e curiosità del periodo all’ascolto di brani dall’album.
La trasmissione corre veloce e si arriva ai saluti ma, mentre uno dei due ragazzi dà appuntamento ai fan al prossimo venerdì, saluta e se ne va, l’altro invece rimane e invita il pubblico a restare sintonizzato poiché la prossima ora sarà interamente dedicata al nuovo “sound” che sta sconvolgendo il Regno Unito, il punk! Ohilà… e li mi blocco. Senza por tempo in mezzo, il tipo spara subito New Rose dei Damned! Sono basito, folgorato da quella scarica adrenalinica, bellissima e folle della durata di tre minuti scarsi… dopo è tutto un susseguirsi di Ultravox, Pistols, Saints, Sham 69, Rezzillos, Jam, Adverts, Clash, Buzzcoks etc… è una vera rivelazione, il verbo disvelato… fatico a prender sonno e la mattina dopo sono già da Nannucci (ancora non sapevo del Disco D’oro in via Marconi) in cerca della mia dose di ribellione musicale che per me prende la forma di No More Heroes degli Stranglers in cassetta poiché a casa non ho lo stereo ma solo il summenzionato radio registratore Philips.
Per un pezzo quella cassettina sarà il mio unico reperto punk, almeno fino all’acquisto di uno stereo da battaglia ma col suo bel piatto per i vinili (grazie proprio a Laura dei Raf Punk). L’incontro coi primi veri punk in carne e ossa avvenne diversi mesi dopo, nel marzo del ’79. Nei miei pellegrinaggi alla facoltà di lettere in via Zamboni avevo notato su muri e colonne dei manifestini che annunciavano uno strano concerto dal titolo “Gaz Nevada sing Ramones” in quel del Punkreas, una cantina dietro la questura! Bastò la parola Ramones scritta a caratteri cubitali a farmi decidere seduta stante. Per cui convinsi i miei amici a rinunciare (per una volta!) al trito rituale del cinemino del sabato sera (solitamente all’Alfa, un parrocchiale economico, dalle sedie scomode, ma poteva essere pure il San Martino nell’omonima piazza bolognese) per andare a esplorare nuovi e più eccitanti lidi.
Così ci ritrovammo, una volta attraversata la porticina d’ingresso e scesa la stretta scalinata, dentro al Punkreas. Uno stanzone spoglio e disadorno ma pieno zeppo di gente. Compagni del movimento, autonomi, freak, tossici, reduci del ’68 e del ’77, maglioni peruviani e collanine, barbe incolte e cuffie di lana, jeans stinti e Clarks color kaki. Poi d’improvviso da un minipalco in fondo alla sala si sente urlare ONE-TWO-THREE-FOUR…ed è l’inizio del diluvio sonoro! I Gaznevada si lanciano in un set al fulmicotone dove sciorinano, una dopo l’altra, tutte le hit dei fratelli Ramone!! Un delirio epilettico avvolge tutti i presenti che si contorcono come indemoniati ed è allora che li vedo, pochi metri davanti a me.
Tre punk fatti e finiti che ballano tra loro con movenze rallentate, incuranti del delirio che li circonda. Mostrano un aplomb incredibile e un look strafigo ma che (in quel contesto) risulta quasi irreale. Lui, il ragazzo, ha un giubbotto di pelle zeppo di spille, scritte, simboli e indossa un paio di bondage trousers con tanto di zip e tiranti. Loro, le due ragazze, sono uno schianto in minigonna di pelle, calze a rete, tacchi a spillo, giacca in cuoio rossa una e maglietta leopardata l’altra, entrambe ornate di spille e catenelle. I capelli sono ultra blond, sparati sull’una lisci invece sull’altra, il trucco è pesante e a mio avviso sono bellissime. Rimango rapito a osservare questa vi sione finché, chiamato dagli amici, mi allontano qualche minuto. Quando torno non ci sono più. Spariti.
Seppi solo molti mesi dopo, quando li incontrai e conobbi al Disco D’Oro, che si trattava di Jumpy, ora Helena Velena, e della sua compagna Laura (fondatori e nucleo storico dei Raf Punk) mentre l’altra ragazza, la dea bionda dai capelli lisci era la loro amica Elettrolux (sparita poco dopo verso altri lidi e altre storie). Coi Raf nacque così un’intensa frequentazione che gettò le basi del Bo-Punx, un periodo unico e speciale, denso di iniziative e concerti, fanzine e autoproduzioni, incontri e discussioni mai visti prima sotto le due torri e di cui troverete traccia nel romanzo a seguire. Buona lettura quindi e …


(l’animo punk da sempre irrequieto per natura)
[la staticità opprimente della piccola provincia borghese, nella sua stagnante mediocrità di pensiero e monotonia latente, dove il perbenismo conservatore tacciava i giovani non omologati come elementi da relegare a comunità di recupero (tanto più per figure inclassificabili alle definizioni sociali che ostentavano «simboli e scritte di rivolta su giubbotti di pelle e capelli colorati dritti in testa») era sicuramente invisa alla mia indole di teenager contraddittoria e riottosa, decisa a spaziare ed esprimere il mio pieno volere di crescere indipendentemente]
“cos I can’t stand the peace and quiet and all I want is a running riot”
In giro per l’Italia avevo già incontrato diversa gente con cui tenevo i contatti per novità su concerti e uscite di dischi: cose difficili da scoprire, essendo le sole news ufficiali divulgate dall’allora fanzine-rivista Rockerilla, finché un’estate conobbi lo Sheriff, Gabri dei Rip Off e Gianni Squilibrio (primi Nabat) che insieme ad alcuni dei Dioxina, Roberto Tax Farano (pre Negazione) e altri, si trovavano a Riccione e fu «l’inizio della rovina»: dopo qualche giorno trascorso con quella teppa iniziai a frequentare regolarmente Bologna (2mila lire e 50 minuti di treno) dove il meeting point per tutti i punx era il Disco D’Oro, un negozio sotto i portici di via Marconi. Fra i tanti, Electrolux, Cinzia “Tracy Crazy” Sirotti (RIP), Rudy (Dioxina), Pecos (Irah), Forti (Irah), Riccardo (Nabat) e Marinella, Pedro (Stalag17), Mammo (Raf Punk), Romano (Stab), Nevro (Urban Fight), Gaiba-Alex (Anna Falkss), Anfe (Uxidi), Steno (Nabat), Susi e Stiv Iena (Nabat/Skrewdriver), Bistek (Impact) e altri che lo Sheriff rinominò con soprannomi rimasti nel tempo: Skinino (Nabat / Urban Fight / Jack Daniels Lovers / Tribal Noise / Wu Ming Contingent), Crema (Rip Off / Wretched), Pugnaro (RIP) e Rozzi (entrambi Rip Off), Morbido, Camacho e non ultimo UiUi (Nabat) sex symbol perennemente in t shirt dei Clash. Una vera Bologna Barmy Army. Sheriff e Destroy invece erano stati battezzati durante i soliti accertamenti e perquisizioni ingiustificate: Marco aveva la patch “Destroy” sul chiodo, Sandro portava tre cinture borchiate. “Minchia e tu chi sei? O’ Sceriffo?” gli fece il poliziotto con spiccato accento. L‘associazione di idee era di una logicità disarmante.
Il ritrovo era anche motivo di scambio di materiale come la fanzine Oi! “Banzai” (Capitano e Keith) oppure la anarco “Attack” distribuita da Jumpy e Carlo dei Raf Punk. Non ricordo di avere mai comperato nulla da Achille e Mortimer, gestori del negozio, forse perché per me il punk è sempre stato principalmente uno stile di vita, la cui musica era un veicolo espressivo di un disagio generale che accomunava i kids cresciuti durante gli anni di piombo, cibati a merendine preconfezionate, sedati da una parvenza di benessere economico.
“don’t know what I want but I know how to get it”
Se punx e skinheads incuriosivano i passanti, certamente attiravano i media. Capitò spesso che fotografi di varie riviste cercassero di rubare qualche scatto. Conservo ancora uno di quei ritagli di giornale che ci riprendeva con chiodi zeppi di patch e stencil di A cerchiate con la dicitura «punk rock e divagazioni amorose». Era evidente che la stampa popolare non avrebbe mai potuto essere una nostra portavoce. La scena, nelle sue diverse sfaccettature, giustificate dall’ancora giovane età dei suoi attori, era comunque uniformemente stimolata da una grande voglia di agire sempre e solo «contro». La società forgia i singoli a essere parte di una massa uniforme. Il sistema li indottrina con dogma prestabiliti. L’individuo pensa e rifiuta. Ribellarsi è giusto.
“do they owe us a living? of course they fucking do!”
La ribellione in sé era non solo più motivata ma anche più genuina e spontanea delle pseudo rivoluzioni strascicanti iniziate dai cosiddetti sessantottini di cui Bologna era capitale. Il fascismo era morto, il comunismo pure, l’era del “produci, consuma, crepa” avrebbe dettato legge. Fra il braccio armato del nichilismo, espressione dell’azione più diretta del sovvertimento, e il purismo anarchico radicale del pacifismo modello crassiano, i punx a Bologna si facevano portavoce di un attivismo pari solo alla lotta militante del contingente lombardo del Virus di Milano.
“una bella guerra civile, franca, aperta, vale mille volte più di una pace corrotta: sarò anche pacifista ma ve la farò pagare”
Bologna era coinvolgente anche solamente perché i concerti radunavano kids da ogni dove; i Clash in Piazza Maggiore, boicottato in primis per essere stato ideato e patrocinato dal comune, documentato in diversi racconti e video dagli stessi picchettatori Jumpy Velena e Steno. C’erano locali come il Tilt a Ceretolo, dove la domenica pomeriggio il dj set era solo punk, o l’Osteria dell’Orsa, che ospitò il primo concerto dei Nabat. Andai a Siouxie and the Banshees con Mammo. Ricordo Adam and the Ants al teatro Manzoni presentato da Red Ronnie accolto con un bagno di sputi. Damned sempre al Manzoni. Rubella Ballet portati dai Raf Punk. Alla sala Cento Fiori di Corticella uno storico all dayer con Anti, Irah, Wretched, Impact, Indigesti. Exploited al Paladozza. Definitivo in quella occasione il mio rifiuto di pagare l’entrata in concerti dove la speculazione degli organizzatori era evidente e contraria alla filosofia Do it Yourself (DIY). Entrai gratis grazie a Sergio dei Centocelle City Rockers di Roma, ingaggiato come servizio d’ordine della band.
“punk’s not dead. I know it’s not”.
Esistevano comunque spazi maggiormente idonei a rivalutare le potenzialità di questa controcultura in crescere come il Baraccano, dato in concessione dal comune di Bologna agli Anna Falkss come sala prove, il circolo anarchico al Cassero di Porta Santo Stefano, ritrovo dei Raf Punk e centro direttivo per le iniziative promosse dal collettivo, e il Casalone a San Donato (ora Covo). E mentre il Disco D’Oro, trasferitosi nell’attuale via Galliera, vedeva un numero sempre più grande di assidui frequentatori da ogni parte, conobbi Albano (RIP) e Unni dalla Norvegia (RIP) che abitavano al civico 19 della stessa via. Con le mie cose in uno zaino mi spostai al secondo piano, ospite degli occupanti che lo condividevano: Destroy, Sandrina e Trippo. Albano, insieme a Mino, Pilò, Mauro, Cicillo, Mara (RIP) e Unni, stavano al primo. Al terzo e ultimo c’era la Grog con altri. Il pianterreno era stato adibito a sala prove insonorizzata. Bologna aveva le okkupazioni!
“some dirty squatters moved into my street with their non sexist haircuts, dirty feet, their dogs, cats, political elite”
Esistevano altre squat: via del Porto, via Borgo Nuovo… case sfitte in pieno centro recuperate come alloggi e ripristinate con impegno dagli occupanti per renderle vivibili e trasformarle in piccoli centri di ritrovo. Il vicinato non era indifferente a questa realtà e ai banner sovversivi appesi fuori dalle finestre, tuttavia ricordo un clima sempre benevolo nei nostri confronti. Un negoziante ci regalò pure i letti. «born to lose live to win» fu il tatuaggio ad ago che mi fece Riccardo dei Nabat proprio sul terrazzino del secondo piano: una prima tacca. Via Galleria mi ospitò fino alla mia partenza definitiva dall’Italia nell’83, la libertà di espressione, il rigurgito delle imposizioni, le amicizie storiche rappresentarono la mia “via di scampo”: feci parte di un forte movimento di rifiuto dei costumi sociali preconcetti con nuove tematiche dissidenti che aveva preso piede attraverso autogestioni, occupazioni, iniziative DIY, generando un modello di organizzazione per i successivi centri sociali nel resto d’Italia e consentendo lo svilupparsi di future realtà anti-establishment.
“decontrol decontrol we’ve been shit on far too long”


Questa storia si svolge in qualche modo prima degli anni 80, anche se termina nell’83 e riguarda tutti i miei amici di quegli anni, i punks e gli skinheads. Cinque anni di interzona, né settanta né ottanta, quelli dal 1977 al 1982. Dopo i mondiali di calcio di Spagna arriva l’italiano vero, il made in italy della moda e la Reazione mascherata da socialdemocrazia. Prima, dopo il 77 bolognese, dal punk e dalla new wave in poi, uno spettro di futuri possibili consumati nel fiume di eroina che invade le strade.
La portata della sconfitta dei nostri fratelli maggiori noi l’abbiamo sempre avvertita. Per certi versi loro, gli autonomi, avevano ragione, per altri non capivano più la realtà: un gap temporale di sei mesi era in quei tempi veloci un abisso incolmabile. Gli autonomi: avevano insegnato un’attitudine di confronto e tante buone parole d’ordine, ma ti correvano dietro perché vestivi di nero. Noi per età eravamo rimasti fuori dalla battaglia ma ne volevamo una tutta per noi. Avemmo molte occasioni.
Il libro è vero come può esserlo un’operazione ideologica. Punk e skinhead la propaganda la indossavano, l’ideologia la vivevano, la moda la subivano. Il gusto dell’epoca rifletteva nel gioco di specchi un’ immagine distorta di chi eri che andava a finire nelle “inchieste” sulle “bande giovanili”.
Per qualche anno la lingua del potere ridusse ogni conflittualità alla dimensione ambigua della moda e del fenomeno di costume. Erano lontani, come sempre, dal vero.
Gli anni ottanta.
Quando arrivò il revival rimasi spiazzato.
Io mi sentivo un sopravvissuto già nei novanta, sapevo di averla scampata bella, ero rimasto quasi integro dentro anni che per molti sono stati un frullatore, una condanna. Quindi già il primissimo revival degli eighties, quello connesso alla scena punk all’incirca nel 1991-1992 mi aveva stupito.
Venivo dal Punk, lo seguivo fin dal 1977, fin da quando avevo quattordici anni. Avevo visto la maggior parte degli anni ottanta, dal 1982 in poi, da un punto di vista peculiare, quella di una gang giovanile dalla brutta fama. Di quella gang conosco tutte le incarnazioni, dai padri fondatori Oddone e Skinino fino alla crew che visse i mid eighties in curva Andrea Costa, e quella che si riformò negli anni 90, ancora in curva e in giro per il paese a seguire i suoi gruppi, i Nabat e i Ghetto 84, e così via fino ad oggi. Quando cammino per strada, ancora rasato, con harrington e brogues, posso avvertire che molti fantasmi camminano con me. Posso dire che sapevamo bene il massacro generazionale, sociale, culturale condotto in quegli anni. Non eravamo ignari.
Qualche anno dopo, con il nuovo millennio, comparve una versione trendy e una nazionalpopolare degli ottanta, e vidi una innocua vulgata filtrare nel gusto, nella moda, nell’ideologia e nella propaganda che ha imperato lungo il corso degli ultimi tre decenni.
Figure improbabili assumevano lo status di un culto, tutti gli ottanta ridotti a Prince e Madonna o se andava bene ai Cure e agli Smiths, alla sciagurata alba del mondo in tempo reale. Giovani turchi alla moda elencavano tra precursori e influenze nomi più giusti, sfoggiando una cangiante panoplia di icone. Che cosa parlasse al presente di quegli anni è chiaro: gli anni ottanta sono una colossale, gigantesca mistificazione che si estende nelle conseguenze fino al presente.
Noi viviamo una versione spettacolare e finale di quel volto della Falsa Coscienza che ha preso forma e fattezze in quel decennio.
Gli ottanta sembrano buffamente mostruosi perché l’ideologia in formazione era innestata su corpi e menti in qualche modo ancora vergini- l’alba della società di controllo, del prevalere della cifra sull’umano erano ancora all’inizio. I corpi erano diversi e anche le menti.
Nella visione nostalgica e glamour di quegli anni la realtà delle strade italiane, delle periferie urbane, non poteva certo trovare cittadinanza. Il conflitto tribale che attraversa periferie e stadi nel decennio del garofano rosso, apparentemente distante dal conflitto politico dei settanta eppure connesso a quello dal rapporto che lega fratelli maggiori e minori, fratelli minori privi di speranza e paura, quel conflitto che ha segnato la vita mia e dei miei compagni di strada è stato quasi del tutto rimosso. Avrebbe riverberato sui conflitti attuali, tutti apparentemente identitari, in maniera troppo spiacevole.
Ma se devo dire in poche parole gli anni ottanta, allora ecco: il tempo in cui la borghesia italiana si arricchisce sul sangue dei suoi figli (e di quelli del proletariato, beninteso) riciclando il denaro del traffico di eroina. Ecco il motore della Milano da bere, della rucola e degli osceni panettoni ripieni degli anni ottanta. Ecco il fondo morale di quell’epoca, il non detto, ciò che avvertivamo accadere e che ci stava accadendo.
Brutti e amari gli ottanta consegnati alla storia, brutti e amari per la classe operaia, per noi sale della terra, e certo per gli skinhead, per quelli sulla strada, per quelli che cercavano un po’ di gloria, una piccola gioia ora, andare per la città come folate di vento, incomprensibili, resi potenti dalla testa rasata e dai boots, andarsene in trasferta cioè all’avventura- pensavo fossero stati anni idioti, violenti, la nascita della fuffa mortifera del presente, ma gli anni che viviamo, nient’altro che una mutazione virale di quelli, fanno sì che anche quei giorni duri e pieni di presagi riflettano una luce aurorale attraverso mille storie inesemplari, ora che i presagi sembrano tutti consumati.

